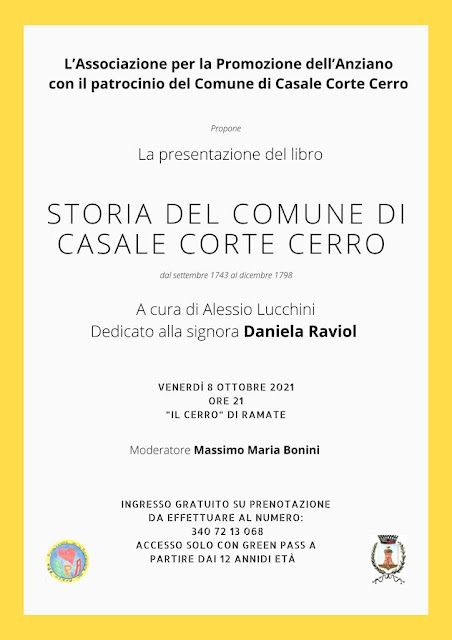Corcera. Termine desueto, di
fronte al quale più di una persona rimarrà perplessa, chiedendosi di cosa mai
si stia parlando. Eppure è il nome del luogo in cui, probabilmente, vive la
maggior parte di coloro che stanno leggendo queste note, la denominazione
antica della valle che scede da Omegna verso Gravellona Toce, delimitata dai
monti Zuccaro e Cerano verso ovest e dal Mergozzolo – si, proprio quel
complesso la cui cima più alta è nota come Mottarone – a est ed è percorsa
dall’ultimo tratto dello Strona, che dopo aver accolto nel suo grembo le acque
del lago d’Orta portatele dalla Nigoglia – quella che orgogliosamente la va a l’in su – le dirige verso il
Toce e il lago Maggiore. Stiamo parlando quindi di luoghi che stanno “dietro
l’angolo” e di percorsi che i nostri vecchi avrebbero definito lä stràa ‘d l’eurt, il vicolo che porta
all’orticello di famiglia, quello che chiunque percorrerebbe ad occhi chiusi.
Mi par di sentire
l’obiezione: “Ma vogliamo perdere del tempo per cose tanto ovvie?” Rispondo:
“Ma siete poi così sicuri di conoscerle davvero?” Dai, lasciatevi accompagnare
per un poco. Vi assicuro che altri, dopo questa esperienza, mi hanno detto:
“Però! Abito a poche centinaia di metri da qui, ma certi posti non li avevo mai
visti e certe cose non le avevo mai sentite”…
Il nostro “esperimento
geografico” inizia proprio dal centro della valle, a Casale Corte Cerro, in
particolare da quel balcone naturale che è il Parco delle Rimembranze della
frazione Motto. Realizzato negli anni ’20 del secolo scorso per ricordare i
numerosi caduti del primo conflitto mondiale – l’elenco completo dei loro nomi
lo si trova poco lontano, inciso in una lastra di bronzo posto sulla parete
meridionale del campanile della chiesa parrocchiale di San Giorgio – fu
ristrutturato nel 1956, quando venne dotato del monumento, opera di Andrea
Cascella, a memoria dei caduti della lotta di Liberazione. Da qui si può godere
del panorama completo della valle, con le pendici dei monti costellate dai
numerosi paesi, il Cusio, il corso dello Strona fino all’ansa del Toce ai piedi
del Mont’Orfano. Una vera e propria carta geografica naturale su cui delineare
il tracciato del nostro percorso.
Partiamo in direzione sud
attraversando la frazione del Motto e passando nei pressi dell'edificio
scolastico, inaugurato nel 1936 e poi più volte ampliato e rimaneggiato. Dopo
il piazzale di parcheggio l'antica strada pedonale – purtroppo in cattivo stato
– corre pochi metri sotto la carrozzabile, che conviene comunque utilizzare,
passando di fronte alla cappelletta devozionale dedicata alla Sacra Famiglia
dai Bottamini, il cui stemma – una botte da cui scorre, abbondante, il vino - è
ancora visibile sul timpano.
Entrati nella frazione
Tanchello si passa dall'oratorio di San Giovanni Battista e San Fermo; curiosa
la banderuola segnavento montata sul campanile: rappresenta la sagoma di un
gufo, a ricordare come gli abitanti della frazione fossero soprannominati ij
oloch, gli allocchi. La stradina passa poi tra alcune case antiche e, salita a
riattraversare la carrozzabile, prosegue tra prati e boschi, su un fondo che
mostra ancora, a tratti, l'antico acciottolato, passando per zone che portano
nomi evocativi dell'antica cultura contadina: Staunogn (intraducibile), Costalvèr
(la costa verde), Lavandér (il luogo delle fonti), fino a raggiungere
l'abitato di Montebuglio.
Buglio – il prefisso di
Monte gli fu aggiunto artificialmente solo a metà '800 - è sede di una comunità
molto antica, citata dai documenti d'archivio sino dai primi decenni
dell'undicesimo secolo, e orgogliosa della sua autonomia comunale, che mantenne
sino al 1869, quando fu forzatamente aggregata al comune di Casale.
Attraversando il paese si possono ammirare diverse abitazioni signorili di
stile settecentesco, adorne di logge a colonnati e ornamenti architettonici che
denotano la prosperità degli abitanti. L’insegna del circolo operaio porta
l’immagine della falce di luna, a ricordo della leggenda secondo cui i
montebugliesi si potrebbero definire ‘astronauti ante litteram’. La
parrocchiale dedicata a San Tommaso apostolo ha anch’essa storia antica ed è
tutt’ora sede di parrocchia autonoma, istituita nel 1629 per distacco da
Crusinallo. Di fronte alla chiesa si trova la grande cappella ossario di
fattura settecentesca, ultimo residuo dell’antico camposanto che, come in quasi
tutti i nostri paesi, un tempo circondava l’edificio sacro, quasi a voler
mantenere uniti i vivi ai loro cari trapassati. L’usanza terminò nel 1805,
quando il regime napoleonico, con l’editto di Saint Cloud di foscoliana memoria,
impose il trasferimento dei cimiteri – con tutti i loro precedenti ‘inquilini’
- lontano dai centri abitati per ragioni sanitarie.
Dalla piazzetta ci dirigiamo
ancora verso sud e percorriamo il ponte che attraversa il rio Loneglio. Da qui,
guardando a monte, si intravede il rudere di un vecchio mulino: un artigiano
locale vi aveva impiantato la sua attività metalmeccanica sfruttando l’energia
idraulica del torrente fino a che un bel giorno, osservando la moglie che
faceva il bucato con la lichiveuse –
la macchina liscivatrice che precorse le moderne lavatrici – non concepì l’idea
di applicarne il principio di funzionamento a un piccolo marchingegno di
alluminio che, sfruttando la pressione del vapore, spingeva dell’acqua
surriscaldata a passare attraverso uno strato di polvere di caffè. Fu così che
il montebugliese Alfonso Bialetti inventò la moka express, sulla quale fondò il
suo impero industriale, portato poi alla fama mondiale dal figlio Renato, il
mitico ‘Omino coi Baffi’.
Lasciato definitivamente il
territorio di Buglio, a monte del cimitero nuovo imbocchiamo un tratto della
vecchia strada per Gattugno, abitato che raggiungiamo in pochi minuti di
cammino e che segna il punto più alto del nostro itinerario. Prima di iniziare
la discesa ci soffermiamo nella piazzetta, con il piccolo parco che divide
l’oratorio dedicato alla Madonna della Neve dall’edificio che fu il municipio
del comune di Cranna Gattugno, soppresso e annesso a Omegna – così come
Crusinallo, Cireggio e Agrano – con la legge di riordino degli enti
amministrativi promulgata dal governo fascista nel 1926.
Scendiamo seguendo ancora
l’antica strada pedonale, costeggiamo un prato recintato con lastre di serizzo,
alcune delle quali recano evidenti segni di coppelle, e raggiungiamo l’altro
nucleo del vecchio comune, Cranna Superiore. Il nome però è ormai finito del dimenticatoio,
sostituito da quello di San Fermo, dal grande santuario seicentesco che gli
emigranti dal paese costruirono per il culto al santo legionario romano, uno
dei martiri della Legione Tebana fatta decimare dall’imperatore Massimiano nel
286 per il rifiuto opposto da quei soldati, già convertiti al cristianesimo, a
partecipare alla persecuzione degli Helvezi, nel basso Vallese. Il santo è
conosciuto in tuta la zona come potente taumaturgo, tanto che la chiesa
custodisce una ricca collezione di ex voto, molti dei quali di forma anatomica,
cioè riproducente la parte del corpo del devoto che sarebbe stata guarita per
intercessione del patrono. Per lo stesso motivo nel salto roccioso che sostiene
l’edificio è presente una cavità che, secondo la leggenda, era destinata a
lazzaretto ove confinare gli appestati.
Da San Fermo il percorso
riprende una delle strade pedonali che, scendendo lungo la forra del rio San
Martino porta al Cassinone, piccolo nucleo al confine tra Omegna e Casale, da
cui, seguendo la strada provinciale possiamo ritornare al centro di Casale
Corte Cerro, chiudendo così l’anello del nostro giro.
Come promesso, una facile
passeggiate di poche ore alla scoperta di alcuni di quei piccoli, ma tanti,
‘tesori’ che fanno così ricche e interessanti le nostre montagne.
Alla prossima.
Massimo M. Bonini – barbä Bonìn
per Alpe Nostra
bollettino della sezione CAI di Omegna
giugno 2017